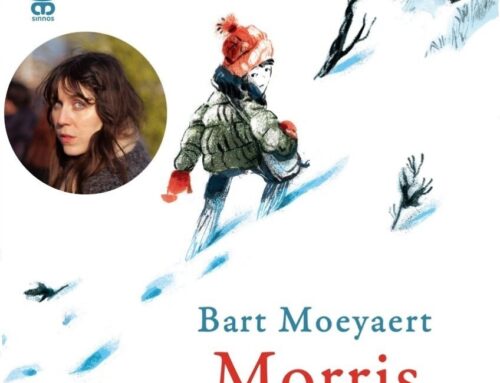IL LATTE DEI SOGNI
IL LATTE DEI SOGNI
Leonora Carrington, trad. Livia Signorini
Adelphi, 2018
Quell’album, molto tempo dopo, Leonora lo regalò a Alejandro Jodorowsky in partenza per Parigi, che lo conservò come una reliquia preziosa e dopo la morte della pittrice, nel 2011, lo restituì a uno dei suoi primi destinatari, Gabriel Weisz. A sua volta, Weisz lo passò al Fondo de Cultura Económica, storica casa editrice messicana, perché lo trasformasse in due libri bellissimi, usciti nel 2013 e intitolati entrambi Leche del sueño: uno, di grande formato, è un perfetto facsimile dell’originale, in cui appaiono la svelta calligrafia dell’autrice, le sue cancellature e perfino le macchie della carta; l’altro, quasi un tascabile, offre ai bambini di oggi una versione più nitida e ordinata del testo e delle illustrazioni.
Riprendendo una definizione dello stesso Weisz, si potrebbe dire che il primo è un libro d’arte con l’aggiunta di storie, e il secondo un libro di storie con l’aggiunta di una buona dose d’arte. È questa seconda versione «infantile» di Il latte del sogno (pp.60, euro 15,00) che Adelphi, editore italiano di tutte le opere di Carrington, manda adesso in libreria nella traduzione di Livia Signorini, basata sull’edizione in inglese e non sullo spagnolo incerto e un po’ sgrammaticato dell’album, legato a un uso prettamente domestico e familiare.
Anche se non possiede le suggestioni del facsimile, così evocativo e personale, il libro offre ai bambini e agli adulti molteplici occasioni di lettura, in cui a volte è il testo a prevalere sulle immagini, tracciate in punta di penna con inchiostro seppia, e a volte è l’immagine a proporsi quale racconto suscettibile di ulteriori invenzioni ed elaborazioni, come nel caso del señor Baffo Baffuto, un Giano con due facce che divora mosche, della sua orrenda figlioletta bifronte che mangia ragni, e di una filiforme consorte sempre a testa in giù, senza braccia e con due minuscole ali da cherubino.
Proprio come nei suoi tenebrosi racconti per adulti, anche in quelli per bambini Carrington scatena un popolo di ibridi e mostri, di creature composite e grottesche alla Jeronimus Bosch, imparentate con miti e leggende provenienti da varie culture (da quella celtica, che segnò la sua infanzia, a quella maya), ma li usa solo per suscitare risate e stupore. Quando non si limitano ad esibire la loro affascinante stranezza, come in «La storia nera della donna bianca», in cui una signora dal ricco abito color carbone («neri i pigiami e pure il sapone») piange lacrime verdi e blu simili a pappagallini, i personaggi vivono avventure di assoluta stravaganza, allegramente crudeli, dove le metamorfosi più drastiche avvengono con perfetta naturalezza e si esplorano senza timore differenze e paure, tra rose spalmate di carne di capra, intingoli disgustosi e parlanti, avvoltoi in gelatina, bambini che hanno una casa in miniatura al posto della testa, o vengono morsi dai buchi del divano, o sono decapitati da una strega e ricomposti da un indio sciocco che incolla le teste nei punti sbagliati, dalle natiche alla pianta del piede.
«Credo che nessuno di noi possa sfuggire alla propria infanzia», ha detto Carrington in una delle sue ultime interviste, e, attraverso ogni più piccola manifestazione della sua arte, ha voluto ricordarci che, al di là di ogni stereotipo, l’infanzia è uno stato d’animo, un prezioso serbatoio al quale si può attingere fino alla fine.
Età di lettura consigliata: 8+
(recensione a cura di Francesca Lazzarata, tratta da Alias, Il manifesto, del 23/12/18)